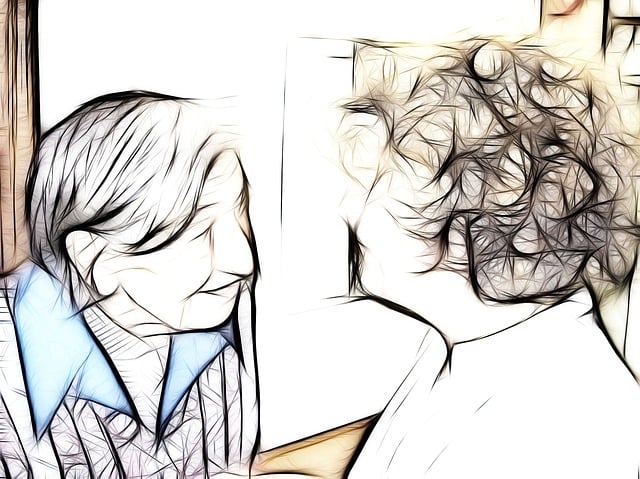di Paola Nannelli *
Stavo seduto a bere e non mi accorsi del buio
Finché cadenti petali mi empiron le pieghe dell’abito
Ebbro mi alzai camminai verso il ruscello lunare
Gli uomini erano radi e gli uccelli non c’erano più
LI PO
Domande… che aprono spazi e pensieri.
A partire a che età può avere un senso una psicoterapia analitica? E fino a che età?
Che senso (o sensi?) ha una psicoanalisi con pazienti anziani?
Ci sono specificità rilevanti nel trattare con persone anziane?
Ma ci sono pazienti anziani?
L’anziano o il grande vecchio sono così diversi dall’adulto?
L’avvicinarsi della morte cambia l’identità delle persone? Le uniforma in una massa di esseri senza nome né storia, ma con solo la prospettiva di chiudere il loro ciclo di vita? Oppure finché vivono possono aver bisogno e godere dell’aiuto, di un ascolto rispettoso, di una persona, con il ruolo di psicoanalista, accanto a loro, di un legame?
Siamo alla ricerca di risposte attraverso due casi clinici.
Chiara (79 anni): sull’ansia e sull’autostima
Chiara mi viene inviata dal figlio, mio lontano conoscente. <<La mamma ha problemi di memoria, teme di avere un inizio di demenza, ma tutti gli esami fatti disconfermano questa ipotesi. La paura e l’ansia sono forti, serve aiuto, le ho proposto di venire da te e lei ha accettato>>.
Un punto è chiaro, gli invii di pazienti anziani non mi vengono dai medici; i geriatri, neurologi o psichiatri che li hanno in cura sono silenti sulle prescrizioni di psicoterapia o sostegno psicologico, e sono invece altre figure professionali ad avermi negli anni inviato pazienti anziani. Su questo tema c’è da soffermarsi, e mi chiedo quanto la mia esperienza sia rappresentativa.
Sul piano della ricerca aderisco ad una Associazione di geriatria, psichiatria e neurologia che organizza convegni molto interessanti, e pubblica una rivista valida e seria; da anni accanto alle tre branche che ho detto c’è anche la psicologia, ma mi risulta che la classe medica fatichi a riconoscere e assegnare un ruolo terapeutico alla psicologia. Lo spazio conquistato con grande fatica e impegno da colleghi forti e motivati ha certamente valore ma poche sono poi le prescrizioni, poco o nullo il riconoscimento nella concretezza della cura, anzi delle cure per i singoli pazienti.
Chiara alla prima seduta non arriva; io aspetto, al telefono non risponde poi decido di scendere per strada. Salgo per Via San Lorenzo, dove ho lo studio, e all’altezza della cattedrale vedo una bella signora che si guarda intorno con aria spersa. Non la conosco, decido di osare e sì, era proprio lei, così andiamo insieme nel mio studio e iniziamo una storia lunga un anno, interrotta dalla paura del Covid, e poi ripresa per poche sedute a settembre 2020, sedute di saluto.
<<Se lei voleva rafforzare la mia autostima, ci è riuscita!>>, questo è stato il suo feedback, finale.
Il lavoro si è svolto con regolarità, non era difficile lavorare sul setting perché gli inciampi sull’orario erano frequenti, arrivare era spesso un’impresa per lei; con pazienza abbiamo cercato di limitare l’ansia che era causa ed effetto di queste sue delusioni sugli orari degli appuntamenti, ho cercato di normalizzare ed evitare che la paura di un futuro “senza testa” peggiorasse il suo stato.
Ho fatto mia la diagnosi del neurologo a cui aveva chiesto un consulto, e con quell’assunto ho lavorato con lei.
Ma, mi sono chiesta e anche ora a distanza di anni mi chiedo: se ci fosse stata una diagnosi di demenza il mio atteggiamento nei suoi confronti e nei confronti del nostro lavoro, di noi due che parliamo in una stanza (Nissim Momigliano 1984), sarebbe cambiata molto? Di certo sarebbe cambiato, ma vale la pena di scommettere (Pascal, 1864) sulle capacità residue piuttosto che sulla perdita della ragione. Chi è perfetto scagli la prima pietra…. Anche su me stessa devo fare i conti coi limiti della mia ragione, quindi posso o devo fare lo stesso con gli altri. Quindi sì, ho scommesso sull’utilità del credere nelle sue capacità, per lei e davanti a lei, con lei, in modo che anche lei potesse confrontandosi con i propri limiti, credere ancora in se stessa e magari togliere le pietre per non inciampare.
Per la strada al nostro primo incontro infatti mi aveva detto: <<Potevo portarmi nella borsa il foglietto con scritto il suo indirizzo, invece ho provato a ricordarmelo e non ci sono riuscita. Che vergogna! Vede come sono? Sto perdendo la testa!>>.
Forse no, cara Chiara, stavi chiedendo troppo alla tua persona, anche in quel caso, come avremmo visto in molti altri, ponevi le condizioni per poterti confermare che eri deficiente, incapace di vivere abbastanza bene, sulla strada della perdita dell’indipendenza.
E’ bastato scommettere sulle sue capacità, e lei stessa ha trovato le vie per riprendersi in mano la vita e potersi dedicare alle cose che le interessavano.
Certo, gli ultimi mesi di terapia vedevano alternarsi i due temi, la sua incapacità e la sua assertività, ma pian piano il secondo si è fatto più importante e le sedute la vedevano confrontarsi sul suo rapporto con le persone prepotenti della sua comunità, sulle amicizie così importanti e forti, sulla grande passione del vedere il tennis in TV, sull’accanita lettura, sui forti affetti familiari… insomma, sul legittimarsi, e difendere dalle critiche interne i tanti aspetti vivi e vivaci della sua persona.
Ci siamo riuscite! Siamo riuscite a far sì che lei riuscisse ad usare le sue capacità, evitando che il senso di impotenza la possedesse. Siamo riuscite a credere nel presente e nel futuro, nonostante i limiti. Siamo riuscite a capire che le serviva attrezzarsi, per limitare i fallimenti. Sì, siamo riuscite a rafforzare la sua autostima, come ha detto Chiara stessa, lei col suo impegno, la fiducia, l’intelligenza e la sensibilità, io col mio lavoro impegnato e appassionato.
“Pensavo che fosse uno scherzo!” Una psicoanalista da Anna Maria, 90 anni
Succede che una persona sia sola al mondo, o forse quasi sola perché qualche antica amicizia è sopravvissuta.
Succede che possiamo chiamarla col suo vero nome visto che è mancata anni fa e non ha lasciato eredi o familiari.
Succede che ci sia un avvocato amministratore di sostegno che ha cura dei suoi amministrati e che mi cerca perché vada da una di loro, una signora novantenne, che vive nella propria casa con una badante.
Succede… non è per nulla scontato!
Agli anziani, ai molto anziani si dà già tanto, e loro danno così poco, pare; gli anziani sono un costo, e non producono; gli anziani invalidi sono faticosi da gestire. La loro cultura, la loro esperienza sembra non servano, così proviamo ad impegnarci per il loro benessere psico-fisico perché arrivino a morire senza troppo costare al nostro stato, privato o pubblico, individuale o sociale. Tutto questo è comprensibile, ed è spesso reale, ma con infinite varianti, come ben sappiamo!
Il 20 gennaio vado in casa di Anna Maria con l’avvocato, suo amministratore di sostegno, parliamo, le prospettiamo degli incontri con me, e lei accetta.
Il 25 vado per la prima seduta, che si svolge fra la sua presentazione di sé e della sua storia e l’individuazione di obiettivi per il nostro percorso, e all’atto di salutarci mi sento dire <<Sa? Pensavo che fosse uno scherzo che una psicologa volesse venire da me, che sono in queste condizioni. Sono rimasta sorpresa>>.
Anna Maria ha la pelle del volto liscia e dei bei capelli ondulati, ha 90 anni, ha difficoltà sia fisiche sia psicologiche, non può più camminare ed è seguita da un neurologo per la depressione; si rifiuta infatti a volte di mangiare, si rifiuta di scendere dal letto per sedersi sulla carrozzina, a volte rifiuta la terapia farmacologica, rifiuta di guardare la TV e giocare a carte con la badante.
La badante è una donna rumena di mezza età, ha cura di Anna Maria e si lamenta con me del carattere della signora; forse la badante in orario di lavoro va a fare pulizie nelle case, lasciando sola la sua assistita, che me lo rivela con cosciente dispiacere. Forse!
Ho quindi seguito a cadenza settimanale Anna Maria per 9 mesi, andando in casa sua, in camera sua, sedendomi vicino al suo letto.
Anna Maria mi ha detto di sé, della sua vita e dei suoi pensieri, quelli del passato e quelli del presente, mi ha confidato sue paure e sue domande profonde, talvolta ho mediato fra lei e la badante, così nella stanza eravamo in 3. Spesso ho atteso che Anna Maria riuscisse a parlare, a volte era sedata o addormentata, ma solo una seduta è stata totalmente silenziosa; faticavo ad andare da lei, perché non sapevo quel che avrei trovato, se la paziente stanca, oppure arrabbiata con la badante, o triste, oppure vitale e in attesa del mio arrivo, soprattutto temevo di trovarla assopita e di dover decidere come richiamarla e se farlo, eppure sono sicura che qualcosa di buono sia accaduto nei nostri incontri, anche in quelli per lo più silenti, quelli in cui c’erano stati scambi di sguardi più che parole. Perché quantifichiamo? Possiamo accontentarci di un incontro di sguardi, sì, in cui in silenzio ci si dice che siamo lì, insieme. Oppure possono bastare poche parole, che nel suo caso erano piccoli tesori che emergevano dalla solitudine, erano domande sulla vita, ricordi che la interrogavano o la consolavano, erano critiche verso proprie scelte passate o verso le persone da cui dipendeva, la badante e l’avvocato, erano spazi silenziosi in cui mi ritrovava lì.
C’era in lei spesso una lucidità che mi spiazzava, la lucidità di chi sente e pensa, e apprezza di poter confidare e affrontare le proprie ansie e le proprie paure; provavo così ad accoglierle e contenerle, e a lei sembrava bastare che la ascoltassi e la aiutassi a tollerare la confusione che a volte le riempiva la mente. Mi assalivano insieme tenerezza e senso di responsabilità quando mi chiedeva: <<Perché si muore?>>, o mi diceva: <<Ho paura di diventare matta>>.
Mi è piaciuto stare vicina a lei che pensava e si ripensava, e si pensava vicina alla morte con le domande che non chiedevano risposta, ma presenza e condivisione.
I 9 mesi di sedute hanno visto le difficoltà iniziali diventare più lievi, la confidenza crescere, e con essa anche le domande più disperanti, e dopo tante sedute il tema della morte si è fatto sempre più presente, finché alla fine di una di esse per la prima volta mi saluta con un secco “addio!”. Quella notte entra in coma e muore pochi giorni dopo.
Anna Maria aveva viaggiato e lavorato con passione, aveva amato leggere e andare a teatro, aveva amato le piante e i gatti, aveva amato e forse non si era mai sentita amata, quando l’ho incontrata era il tempo di vivere diversamente; la maculopatia da anni le impediva di leggere, e il resto non c’era più da tempo, eppure in un mondo efficiente che non la capiva lei diceva di star bene da sola coi suoi ricordi e i suoi pensieri, lo diceva con franchezza, lo ha ripetuto più volte. Così ha usato i nostri incontri per analizzarsi, per capire che poteva tout perdre sans se perdre (Quinodoz, 2003), per elaborare i suoi vissuti e io ero ora figlia, rappresentante di chi rimane a vivere quella vita che stava per abbandonare, ora genitore, che rassicura e conforta (Volterra, Borsetti, 1986), ma soprattutto ero presenza fraterna che credeva che Anna Maria fosse una persona, con tutto quell’insieme di componenti affettive, progettuali, emotive, intellettive che ogni vita umana comunque ha e con la possibilità di stare meglio nella vita che stava vivendo.
Torniamo ora alle domande iniziali.
Non ho voluto soffermarmi sulle specificità dell’età ultima della vita, perché per esperienza clinica hanno più importanza quelle delle persone, dei nostri pazienti.
Ha valore la presenza di uno psicoanalista accanto ad una persona anziana, anche molto anziana, perché lei ha un presente da vivere e anche un futuro, un resto della giornata, o della vita con cui confrontarsi e ha dei diritti, il diritto di avere affetto, riceverlo e darlo, il diritto all’ascolto, ad essere ascoltata e ascoltare, il diritto di avere dei legami (5).
Torniamo alle domande iniziali e lasciamole aperte, lasciamoci interrogare ancora.
Bibliografia
Horvilleur D., (2023), Capire il mondo, Qiqajon Editore, Magnano (BI), pag.51.
Nissim Momigliano L., (1984), Due persone che parlano in una stanza, in Rivista di Psicoanalisi, vol. 30, n. 1, Edizioni Borla.
Pascal B., (1864), Oeuvres complétes, établis par Chevalier J, Ed. Gallimard, Paris.
Quinodoz, D., (2008), Viellir, une découverte, Ed. Presses Universitaires de France, Paris.
Volterra, V. Borsetti, (1986), Prospettive psicoterapiche nella terza età in AAVV, Psicoterapia dell’anziano, Centro Scientifico Editore Torino, pag.47.
* Paola Nannelli è psicologa e psicoterapeuta